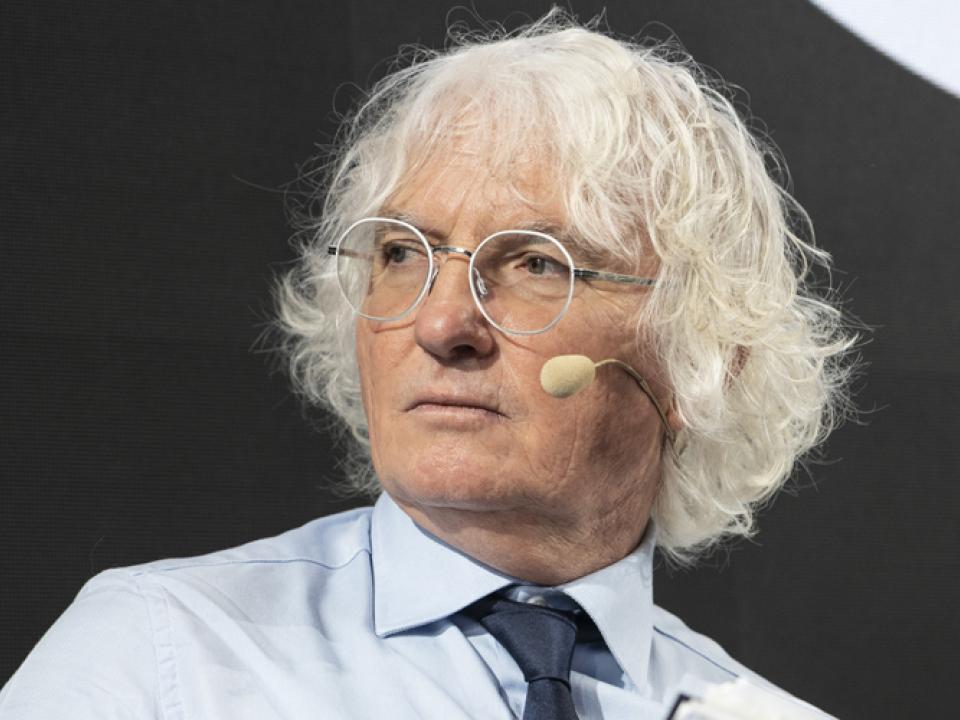Il nomadismo del commercio in Italia è ancora vivo. I dati 2023 di Unioncamere a tal proposito sono illuminanti: un operatore del commercio su cinque in Italia è un ambulante; con oltre 160 mila imprese, il 21% di quelle commerciali del paese, l’attività in sede mobile rappresenta una componente strutturale di grande importanza, non solo economica ma anche sociale. Tale commercio serve 6.200 comuni italiani e a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, addirittura il 73,4% delle imprese commerciali rientra in tale tipologia. Certo, i tempi cambiano e gli ambulanti oggi non sono solo italiani: sempre secondo Unioncamere, Marocco, Senegal e Bangladesh sono gli stati più rappresentati tra i venditori itineranti del nostro paese, sebbene ad Andria il 98% degli appartenenti a questa categoria siano italiani e a Padova lo siano due su tre. Il commercio ambulante, quindi, resta una risorsa importante per l’Italia e conserva quel senso di “nomadismo” che lo porta verso il popolo rispetto al modello della grande distribuzione che invece lo attende.
Probabilmente anche l’ottica sente in qualche modo, ancora oggi, tale richiamo che tanta fortuna portò sino fine dell’800, quando Angelo Frescura smise di fare l’ambulante e aprì una piccola bottega a Padova, nella quale vendeva i suoi prodotti, tra cui pettini ricavati da corna di animale e occhiali di importazione. E come racconta il bel libro Scienze della Visione di Sergio Cappa e Silvio Maffioletti, fu proprio quell’Angelo Frescura a maturare da Padova l’idea di una produzione italiana di occhiali a Calalzo di Cadore, archetipo del distretto dell’occhiale di oggi. Ma perché proprio in Cadore? La scelta “è dovuta principalmente all’abbondanza di corsi d’acqua a potenza rapida che garantiscono quella grande disponibilità di energia idraulica che alla fine dell’800 è una risorsa determinante”, si legge in questo volume. Dove potrebbe condurre l’ottica e l’ottico oggi la ricerca di nuova energia e linfa per il suo futuro? Qualcuno ha ipotizzato all’approdo nelle farmacie, così diffuse in Italia, così trafficate e potenziali nuove frontiere d’accesso alla salute degli italiani.
C’è chi ha recentemente deciso di annunciare un accordo con il mondo delle farmacie a livello locale, che tuttavia non è ancora operativo. Salvo parzialmente rettificare alcuni giorni dopo buona parte di questo piano, sebbene lo ritenga un pungolo per la categoria a fare qualcosa prima che lo facciano altri.
Come fa spesso Striscia la notizia, ci permettiamo di consigliare ai lettori, dopo quello di Cappa e Maffioletti, un altro bel libro, a firma di Vittorino Andreoli: La società del pressappoco. Che cita in seconda di copertina: “Stiamo passando dal mondo della precisione a quello del pressappoco, guidati da un inconsapevole rifiuto della funzione ordinatrice del pensiero: persino la scienza ammette di non giungere alla verità ma solo a conclusioni parziali e provvisorie”.
Nicola Di Lernia